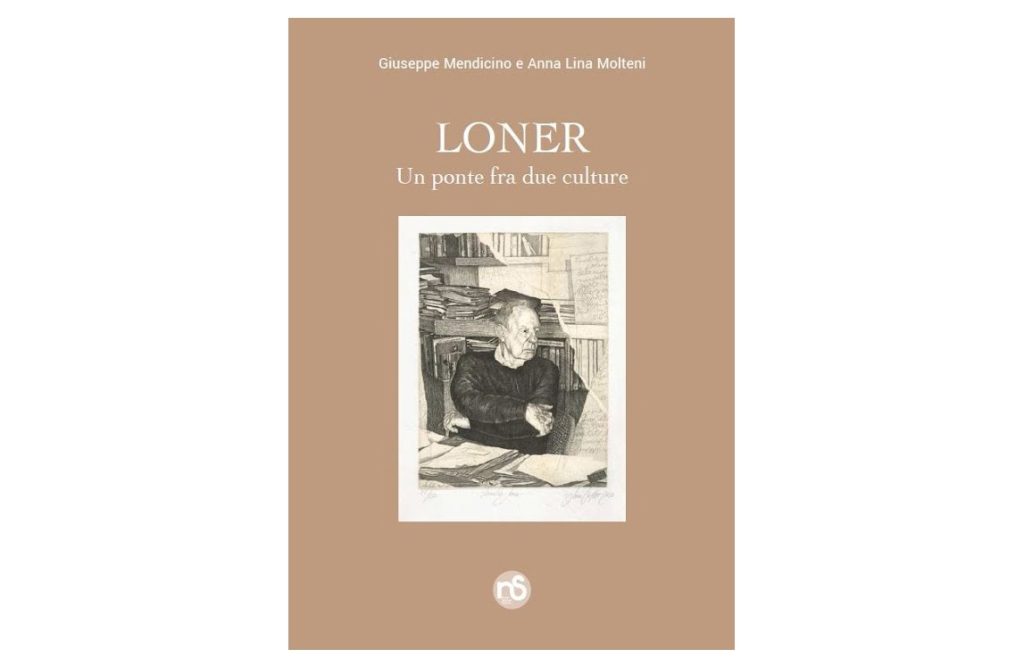Lo spunto
Subiaco (comune di circa 8000 abitanti della Città Metropolitana di Roma) è la Capitale italiana del Libro 2025. A proclamarla, nel corso di una conferenza stampa a Roma, al Ministero della Cultura, è stato nei giorni scorsi il Ministro Alessandro Giuli.
(Ansa)
Quanto bisogno abbia l’Umanità di avviare una nuova forma di resistenza contro il consumismo culturale che, assieme alla violenza verbale, assedia la cultura dell’Occidente fino al punto di metterne a rischio le libertà civili, lo conferma ogni giorno la cronaca, non solo quella “nera” di guerre e delitti, ma quella economica e politica che sembra moltiplicare ingiustizie e prepotenze. È contro questa deriva che il libro si pone come forma di “resistenza” quasi per ribaltare, con la sua concretezza di oggetto, di manualità artigiana (carta, composizione, illustrazioni…), di supporto tattile per i contenuti di vita e pensiero che trasmette, la tendenza ad un approccio strumentale, o astrattamente intellettuale verso il sapere. Non è un “usa e getta”, il libro resta, si conserva, attraversa i secoli recuperandone fascino e saggezza, denunciando anche gli errori della storia che il mondo sembra condannato a ripetere. Ma il libro li avverte, ne racconta e svolge le conseguenze e questo ne fa quasi, come diceva Umberto Eco, il grande scrittore e bibliofilo, uno “strumento d’immortalità”, sia pure “alla rovescia”. Un libro non garantisce, infatti, il futuro, ma ne illumina le potenzialità e al tempo stesso prepara le vite ad affrontarle. Non si esaurisce nel tempo dedicato alla sua lettura, né si riduce ad un accumulo di vecchie carte polverose, ma si pone come punto di riferimento, di identità, capace di accompagnare i movimenti e le svolte di una vita, di colmarne i dubbi, di riempirne i vuoti.
Per questo è importante rammentare la “capitale” del libro (“costruita” nei secoli dai frati di San Benedetto e dagli artigiani cartai e stampatori) come lo è celebrare la “Giornata del libro” stabilita il 23 aprile, per sottolineare quanto questo semplice ma raffinato prodotto diventi quotidianamente, ancoraggio non solo del sapere, ma delle relazioni, dei dialoghi d’umanità, per nulla superato – tutt’altro – dagli evanescenti strumenti del “web”, della rete, che è fin troppo facile lacerare, come risulta altrettanto facile rimanervi impigliati.
Subiaco, dove sorge la grande abbazia benedettina, è stata indicata quest’anno come capitale italiana del libro. Ma fortunatamente la galassia del libro non ha una sola capitale, ma è policentrica, trova le sue piccole e grandi “capitali” in vari luoghi e situazioni, in altre città dove esistono prestigiose biblioteche, (in pubblici edifici o antichi conventi) o in borgate anche remote, dove sono presenti preziosi e volonterosi nuclei di “resistenza” presso piccoli editori, stampatori, collezionisti e biblioteche private spesso di gran pregio perché specializzate con edizioni anche rare. È il caso questo del Trentino e dell’Alto Adige, province che non aspirano ad essere “capitali” librarie, ma presentano ed assicurano patrimoni difficilmente rintracciabili altrove. A Trento la Biblioteca del Castello del Buonconsiglio e quella Comunale, dove sono conservati i preziosi codici musicali del Rinascimento, unici in Europa, ma anche la moderna, fornitissima, Biblioteca dell’Istituto storico italo germanico (per lunghi anni diretta dal cappuccino padre Butterini, seguita con particolare cura e attenzione dai prof. Paolo Prodi e Diego Quaglioni), mentre nella provincia di Bolzano vanno ricordate le biblioteche dei conventi di Monte Maria a Burgusio in Val Venosta (che fornì lo spunto ad Eco per il suo “ Il nome della rosa”) o quelle di Novacella e Gries con 70 mila volumi, trasportati quasi uno per uno come bagaglio personale dai frati quando vi arrivarono nel 1841 dopo l’espulsione dall’Argovia (Svizzera). In vista del convento e della sua biblioteca sorge un altro piccolo gioiello, ed è la casa dell’avvocato Arnaldo Loner, con una delle biblioteche private più preziose dell’Alto Adige, biblioteca di ricerca non solo giuridica, ma etica, di crescita morale della personalità, di documentazione. Loner, di origine trentina, di famiglia cembrana insediatasi a San Giacomo di Bolzano agli inizi del Novecento, s’è distinto come responsabile di uno dei più affermati studi legali della città, svolgendo un ruolo di “ponte” fra le comunità di lingua italiana, tedesca e ladina. Di questo ponte i libri sono stati le pietre portanti, non solo perché, come afferma, gli hanno aperto il cuore oltre che la mente, ma per i collegamenti nazionali e internazionali che gli hanno procurato (è stato molto amico di Umberto Eco) e per gli impegni di testimonianza civile a ambientale ai quali lo hanno preparato. Loner è stato presidente di “Italia Nostra” di Bolzano, interloquendo con padre Welponer dell’Heimatpflege, ma soprattutto ha rappresentato il Comune di Bolzano come parte civile nel processo a “Misha” Seifert, il nazista ucraino-tedesco che fu carceriere e aguzzino nel campo di Via Resia. Ponte anche con la cultura ebraica si rivelò la biblioteca di Loner, oltre che con le realtà territoriali alpine, con il Trentino e in particolare con la Biblioteca Tartarotti di Rovereto.
La Biblioteca Tartarotti ha voluto celebrare la “Giornata del libro” distribuendo ai lettori libri ricevuti dalle donazioni private ma già presenti nelle collezioni. Una biblioteca in casa anche piccola dà “cuore alla mente”, stimola ricerche, apre nuovi orizzonti, e stimola nuove associazioni di idee, anche se i libri non sono stati tutti letti. È una riflessione che si impara leggendo proprio in questi giorni un piccolo libro prezioso, pubblicato meritoriamente da “Nuovi Sentieri” dell’editore alpinista Bepi Pellegrinon di Falcade nel Bellunese. Redatto da Giuseppe Mendicino e Anna Lina Molteni, il libro su Arnaldo Loner (nella foto) si presenta come una biografia sintetica, ma completa, interessantissima per conoscere un uomo, la sua passione di collezionista librario e grafico (stampe e disegni di montagna soprattutto), il ruolo dei libri. Le pagine si aprono con una nota biografica, ma proseguono poi con capitoli che sono quasi racconti: “A Bolzano in casa Loner”, “Ieri ho parlato con i libri della biblioteca”, “Il processo a Michael Seifert”, “Custode della memoria”, “Etica e deontologia professionale”, “Montagne, ambiente, paesaggio”, un libro scandito alla perfezione, che coinvolge pienamente nella lettura, che porta il lettore quasi a colloquio diretto con il protagonista. Un libro che fa della piccola Falcade e di Bolzano due autentiche capitali del libro.