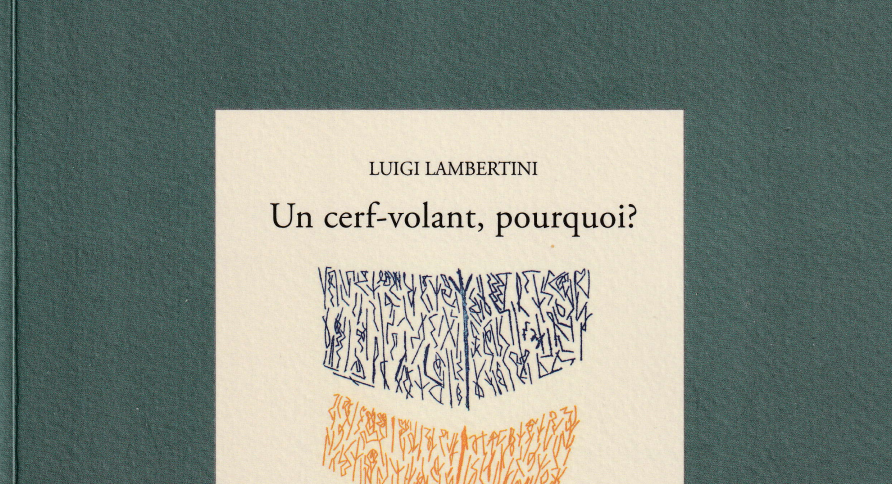Questo libro ripercorre con simpatia diversi momenti della vita dell’autore, Luigi Lambertini, e dell’artista Riccardo Licata, prima da bambini, poi d’adulti impregnati nei mondi dell’arte nei loro diversi aspetti. Lambertini mescola con rara abilità le loro due storie e le loro vite e, raccontandole, ci avvolgono nella freschezza di un’epoca purtroppo scomparsa.
Silvano Gasperini (Venezia)
Sono molte le ragioni per leggere, a Trento, “Un aquilone, perché?” il libro di Luigi Lambertini uscito da poco dal Centro internazionale della Grafica di Venezia nella versione in lingua francese (“Un cerf –volant, pourquoi?”) riscritto e completato a trent’anni dalla prima edizione italiana. Non solo per la simpatia che il suo autore sa comunicare attraverso i momenti di vita che racconta, ma perché la sue pagine riescono a trascinare anche i lettori più lontani o distratti verso quell’azzurro capriccioso e imprevedibile in cui salgono gli aquiloni, portati dal vento che tutto avvolge come lo scorrere del tempo, intrecciando sogni d’infinito con brusche impennate che li fanno poi precipitare.
Prima che il vento ceda alla brina o alle nevicate d’inverno l’invito a inseguire nel cielo l’aquilone di Lambertini diventa quindi una promessa di nuove stagioni possibili, da ricercare e da vivere. Anche perché il libro dà la possibilità a chi ne percorre le pagine di scegliere varie linee di orientamento, di immergersi, oscillando senza strappi, in diverse situazioni esistenziali.
La prima è quella che porta a ricordare (ricordarci) come gli aquiloni delle attese, dei progetti, dei sogni volano anche nei cieli del Trentino, con il vento che s’infila fra le montagne o sale ai pascoli alti fra i boschi, e questo non solo perché, da bambini, tutti abbiamo costruito aquiloni, con le leggere asticelle di balsa acquistate da Italo e le carte veline prese dai quaderni di scuola da foderare.
É vero che nel libro di Lambertini l’aquilone volteggia sopra le Alpi piemontesi e si spinge poi fino a Parigi per affacciarsi a Venezia, ma non dimentica la stagione che l’autore – srotolando il filo che lo tiene legato a terra e al tempo stesso lo fa volare in libertà – ha trascorso proprio a Trento, al suo primo impiego di giornalista Rai, negli anni Sessanta.
Fu quasi un “imprinting” per il giovane di origini bolognesi nato a Nizza (il padre era direttore di grandi alberghi internazionali) la preparazione ad una carriera brillante di giornalista, critico d’arte e scrittore perché a Trento incontrò una realtà politica e culturale in grande movimento, quasi un laboratorio umano europeo, con la questione altoatesina che dagli attentati dinamitardi passava alla pacificazione fra minoranze, l’autonomia che si radicava con Bruno Kessler, l’università, Sociologia e l’alluvione del 1966 che segnò la grande svolta, con la fine della vecchia civiltà contadina e la volontà di riscattarsi da ciò che fango e frane avevano travolto.
A Trento partecipò anche al vivo ambiente comunicativo attorno alla nuova presenza Rai, diretta da Gianni Faustini, e al gruppo letterario che con il poeta Marco Pola, gli amici di Francesca Mosna e del marito prof. Giulio Antonio Venzo e l’editore Giuliano Salvadori del Prato si riuniva attorno alla pittrice-innovatrice Cesarina Seppi.
L’altra dimensione che le pagine aprono è quella del vento fra i monti di Clavières, località montana dell’Alta Val di Susa, in Piemonte.
È qui, dove trascorrevano le vacanze estive, che i due bambini, Licata e Lambertini si incontrano, il primo ospite della nonna nella sua villa, il secondo nel grande albergo che il padre dirige. Ed è qui, proprio attorno all’aquilone che insieme i ragazzini costruiscono e, con stupore, fanno volare, che nasce una comune vocazione, poi maturata lungo percorsi diversi verso l’arte, che è innanzitutto sapersi stupire della vita, osservandone i momenti più dimenticati da punti di vista originali. Così Riccardo diventerà pittore e incisore, fra i più innovativi e conosciuti del secondo Novecento italiano, mentre Luigi si farà strada e fama nella critica d’arte su giornali, riviste, cataloghi, mostre.
Il primo userà i segni come alfabeto di un linguaggio tutto suo, sorretto, come è il vento, da impercettibili vibrazioni ed incisioni, mentre il secondo userà la parola come segno perché idee, esperienze, rivelazioni di bellezza non si disperdano nel nulla cercando di raggiungerlo: senza filo l’aquilone non vola.
Ed è questa la terza dimensione che il libro di Lambertini propone, intrecciando ricordi e momenti di vita, suoi e di Licata, nei loro soggiorni francesi e italiani, con le mogli, gli amici o gli incontri con i grandi pittori di quella stagione per molti versi irripetibile. Ne esce un intreccio di vite che la prosa di Lambertini riesce però a comporre unitariamente, quasi in un comune Bildungsroman, un percorso di formazione al quale, come in “Fiesta Mobile” di Hemingway il lettore vorrebbe accompagnarsi lungo pagine che insegnano non solo a vedere, ma a viaggiare. Ed è questo il motivo, a ben guardare, per cui il libro è stato scritto in francese, linguaggio che l’autore padroneggia per la nascita a Nizza e i lunghi soggiorni oltralpe, ma che non costituisce la sua lingua materna e di lavoro.
Ma come è accaduto per altre opere di scrittori che hanno usato una lingua acquisita, plasmando un materiale espressivo più “lontano”, meno malleabile, ( il pensiero corre inevitabilmente a Conrad) la prosa ne è risultata più efficace e incisiva, con meno sottigliezze e sfumature (che nel ripercorrere memorie, presentano la maggior tentazione di cadere in morbidezze compiaciute) con espressioni essenziali, tali da far desiderare che l’aquilone continui il suo volo e lo estenda ad altri incontri, a nuovi racconti di bellezza e umanità.